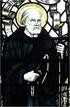Giurista brillante divenuto francescano, il Beato Angelo da Chivasso scrisse la famosa 'Summa Angelica', opera teologica tanto importante da essere pubblicamente bruciata da Martin Lutero come simbolo dell'ortodossia cattolica. Fu anche instancabile difensore dei poveri attraverso la fondazione dei Monti di Pietà per combattere l'usura.
Il Beato Angelo da Chivasso è una delle figure più significative del francescanesimo quattrocentesco, capace di coniugare profonda spiritualità, brillante preparazione giuridica e instancabile impegno sociale. La sua vita rappresenta un esempio straordinario di come cultura e fede possano mettersi al servizio degli ultimi.
Dalle aule universitarie alla vocazione francescana
Antonio Carletti nacque a Chivasso, cittadina poco distante da Torino, intorno al 1410-1411, da una famiglia nobile e benestante. La sua formazione fu di altissimo livello: studiò a Bologna, uno dei centri culturali più importanti d'Europa, dove conseguì il dottorato in diritto civile e canonico, sebbene il suo nome non compaia nei registri ufficiali dell'università.
Rientrato nella sua Chivasso, intraprese una brillante carriera pubblica. Il suo talento non passò inosservato al marchese Giangiacomo Paleologo, che lo nominò senatore e consigliere del Marchesato. Antonio divideva il suo tempo tra i doveri pubblici, la preghiera e l'assistenza agli ammalati, manifestando già quella sensibilità verso i bisognosi che caratterizzerà tutta la sua vita.
La svolta avvenne all'età di trentatré anni, quando, alla morte dei genitori, Antonio decise di abbandonare ogni prospettiva mondana per consacrarsi a Dio. Vendette tutte le sue proprietà, distribuendo il ricavato tra il fratello e i poveri, e donò persino una casa paterna alla comunità per i pubblici consigli. Entrò quindi nel convento di Santa Maria del Monte a Genova, appartenente all'Osservanza di San Bernardino da Siena, prendendo il nome di Angelo.
Un francescano tra i poveri e contro l'usura
Il primo incarico che gli fu affidato fu quello di insegnare teologia ai novizi, ma ben presto il suo zelo apostolico lo portò a predicare nelle zone più remote delle montagne piemontesi. Durante questo periodo, Angelo sviluppò un particolare apostolato rivolto ai poveri, impegnandosi non solo a sostenerli spiritualmente ma anche materialmente.
La sua opera più significativa in campo sociale fu l'impegno nella fondazione dei Monti di Pietà, istituzioni tipicamente italiane nate per contrastare il drammatico problema dell'usura che opprimeva le classi più povere. Come il suo contemporaneo e confratello francescano Beato Marco Fantuzzi, Angelo comprese che la carità doveva tradursi in strutture concrete di aiuto. A Genova e Savona promosse l'erezione di questi istituti di credito che prestavano denaro a tassi minimi o nulli, sottraendo così i bisognosi alle mani di usurai potenti e spietati.
Guida dell'Ordine e difensore della fede
La sua fama di uomo dotto, umile e dalle maniere cortesi lo portò a ricoprire importanti incarichi all'interno dell'Ordine francescano. Nel 1464 fu eletto Vicario Provinciale, primo di una lunga serie di responsabilità. Nel 1472 all'Aquila, alla presenza di duemila frati, divenne per la prima volta Vicario Generale degli Osservanti, carica che ricoprì per ben quattro mandati nel corso della sua vita.
Come superiore, Angelo si impegnò particolarmente nella difesa della Regola originale di San Francesco, viaggiando instancabilmente per l'Italia, spesso a piedi, per visitare i conventi e verificare l'osservanza della disciplina. Durante il suo generalato fondò numerosi monasteri in Piemonte, tra cui quelli di Saluzzo, Mondovì e Pinerolo, e contribuì all'espansione dell'Ordine, che arrivò a contare venticinque province.
Nel 1480, quando i Turchi conquistarono Otranto minacciando di invadere l'Italia intera, Papa Sisto IV lo nominò Nunzio e Commissario Pontificio per organizzare la difesa cristiana contro l'avanzata ottomana. Angelo visitò tutti i regnanti italiani, sensibilizzandoli sulla gravità della minaccia e coordinando una risposta unitaria che, insieme ad altri fattori come la morte del sultano Maometto II, scongiurò il pericolo.
La Summa Angelica: un'opera bruciata da Lutero
Angelo da Chivasso fu anche un importante teologo e scrittore. La sua opera più celebre è la Summa casuum conscientiae, meglio conosciuta come Summa Angelica, pubblicata per la prima volta nel 1476. Si trattava di un manuale di teologia morale diviso in 659 capitoli in ordine alfabetico, che trattava delle varie questioni di coscienza. L'opera ebbe un enorme successo per la sua chiarezza e concisione, diventando uno strumento prezioso per i confessori.
La Summa Angelica ebbe così grande diffusione da essere ristampata almeno trentuno volte prima della morte del suo autore. La sua importanza come simbolo dell'ortodossia cattolica fu tale che Martin Lutero la bruciò pubblicamente nella piazza di Wittemberg il 10 dicembre 1520, insieme alla Bolla di scomunica, al Codice di Diritto Canonico e alla Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino.
Angelo scrisse anche un trattato sul dovere della restituzione e un breve commento alle lettere di Papa Sisto IV. Alcuni studiosi ritengono che possa aver ispirato o addirittura scritto alcune delle opere attribuite a Santa Caterina da Genova, di cui fu direttore spirituale dal 1475.
Gli ultimi anni e il culto
Nonostante gli venisse offerta più volte la dignità episcopale, Angelo rifiutò sempre, preferendo rimanere un semplice sacerdote fedele all'ideale di povertà francescana. Accettò nel 1491, ma solo per obbedienza a Papa Innocenzo VIII, l'incarico di commissario apostolico per la predicazione ai valdesi, una setta riformista condannata come eretica. Con grande zelo e coraggio personale, riuscì a ricondurre all'ortodossia molti eretici e a stipulare un accordo pacifico tra cattolici e valdesi nel 1493.
Infine, nel 1493, poté abbandonare tutti gli incarichi pubblici e ritirarsi a una vita più solitaria nel convento di Sant'Antonio a Cuneo. Ormai ottantenne, trascorse gli ultimi anni nella preghiera e nell'elemosina a favore dei poveri, arrivando persino a questuare per le strade della città.
Morì l'11 aprile 1495 (secondo altre fonti il 12 aprile), povero e umile come aveva vissuto. Il suo corpo, trovato incorrotto e flessibile, emanava un soave profumo. I miracoli attribuiti alla sua intercessione cominciarono subito dopo la morte, tanto che nel 1681 fu proclamato patrono di Cuneo. Papa Benedetto XIV confermò ufficialmente il suo culto nel 1753, fissando la memoria liturgica al 12 aprile.
Oggi il Beato Angelo da Chivasso resta un esempio luminoso di come si possano mettere i propri talenti intellettuali al servizio della fede e dei più deboli, in una sintesi perfetta di contemplazione e azione che rappresenta il cuore dell'ideale francescano.