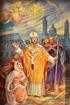- San Gimignano (Toscana)
Santa Fina, al secolo Serafina, nacque a San Gimignano nel 1238 e morì giovanissima all'età di soli 15 anni nel 1253. La sua fama di santità cominciò presto a diffondersi per i numerosi miracoli che le furono attribuiti sia in vita che dopo la morte. Secondo la tradizione, Fina si ammalò gravemente e, nonostante la malattia la costringesse a rimanere a letto su una tavola di legno, mantenne una fede incrollabile. Si narra che San Gregorio Magno le apparve annunciandole la data della sua morte. Dopo il suo decesso, molti cittadini di San Gimignano testimoniarono miracoli avvenuti per sua intercessione. La devozione verso Santa Fina è molto sentita a San Gimignano, dove le sono dedicati una cappella nella Collegiata e un ospedale. La sua festa si celebra il 12 marzo, giorno della sua morte, e in questa occasione la città le rende omaggio con cerimonie e tradizioni secolari.
La patrona di San Gimignano, che ha ispirato pittori e scultori, morì quindicenne dopo una malattia gravissima che l’aveva costretta su una tavola per cinque anni e che lei aveva sopportato con una sorridente pazienza
Ogni anno, alla festa di santa Fina che cade il 12 marzo, i ragazzi di San Gimignano offrono ai passanti delle violette color giallo oro che han raccolto sui bastioni. L’usanza rievoca una fioritura inconsueta che segnò la morte della patrona della cittadina toscana, quando dall’asse di quercia dov’era spirata spuntarono fiori a profusione.
Fina, diminutivo di Iosefına, era nata nel 1238 a San Gimignano, in una famiglia di nobili decaduti, i Ciardi, che vivevano poveramente, come d’altronde testimonia ancora adesso la loro casa. Secondo il suo primo biografo, fra Giovanni del Coppo, che nel 1300 scrisse in latino la prima Vita, poi tradotta in Historia, vita et morte di Sancta Fina da San Gimignano, era una bambina straordinariamente religiosa. All’età di dieci anni, quando già aveva perduto il padre, fu colpita da una malattia «per la quale perdé tutta la persona salvo che ’l capo, e diventò tutta attratta, e per nessun modo si poteva levare dal letto, neanco muoversi niente. Et avvenga Iddio che fusse così infermata, non voleva che ’l corpo suo si riposasse sopra cosa morbida, anzi stava e dormiva sopra una tavola di quercia secca. E perché uno lato del suo corpo era pieno di dolori e molto l’affaticava, ella dormiva sopra l’altro lato, e per ispazio di cinque anni si riposò sopra l’altro lato, e non si lassò mai da nessuno muovere né mutare. E perché tanto giacé sopra uno lato, la carne venne a infracidare, e la tavola a ingenerare vermini, e’ quali vermini si mangiavano la carne di questa santa vergine. Et ancora perché era cosa putrida, ’e topi (perdonimi chi legge) andavano insieme e mangiavano la carne sopraddetta».
Nella descrizione del biografo c’è evidentemente dell’esagerazione, come d’altronde in molti agiografi di quell’epoca il cui intentò più che storico era pio e devoto. Quale fosse invece la gravissima malattia non ce lo spiega. Dai sintomi descritti parrebbe una forma tubercolare, un’osteomielite o una coxite o il morbo di Pott. Quanto alle piaghe infette, erano probabilmente da decubito o forse esiti di osteomielite.
La fanciulla seppe sopportare quella tragica condizione per cinque anni offrendo un esempio di pazienza eroica e insegnando a chi veniva a visitarla e curarla, dopo la morte improvvisa della madre provocata da una caduta, il culto della Passione del Signore e la devozione alla Regina dei martiri.
Poco prima di morire chiese al Signore la grazia di conoscere il giorno della sua partenza. Le apparve san Gregorio Magno annunciandole otto giorni prima che sarebbe mancata il giorno della sua festa, il 12 marzo. Quest’episodio è stato rappresentato da Domenico Ghirlandaio in uno dei tre affreschi che decorano le lunette laterali della cappella dedicata alla santa nella collegiata di San Gimignano.
Appena spirata, i diavoli per rabbia e invidia riempirono l’aria di turbini così spaventosi che la gente ne era spaventata; ma subito dopo una mano angelica suonò le campane cacciando quelle presenze infernali. Anche quest’ultima scena è stata affrescata dal Ghirlandaio che ha dipinto un angelo mentre suona la campana.
A questi prodigi accorse molta gente fino alla casa della fanciulla dove vide miracolosamente fiorita tutta la stanza. Mentre la si levava dalla tavola di quercia, parte della sua carne putrida restò attaccata al legno dove spuntarono prodigiosamente i fiori.
Portato il corpo nella pieve, si moltiplicarono i miracoli. Il più celebre, rappresentato anche dal Ghirlandaio, è quello di Beldia, la sua nutrice, alla quale si era gonfiata enormemente la mano con cui aveva a lungo sorretto il capo della santa. Mentre la balia piangeva accanto al corpo, la santa alzando miracolosamente la destra la prese per mano e la risanò.
Fiorirono poi leggende destinate a diventare popolari e a ispirare pittori e scultori. La più nota è quella di Smeralda e della sua brocca. Un giorno Fina, quando ancora era sana, si recò a passeggiare con due amiche alle Fonti. Mentre stavano ammirando la splendida veduta di ville, borghi e casolari, sentirono una voce piangente: era una bimba di sette-otto anni che si chiamava Smeralda. Piangeva perché la sua brocca di terraglia, che aveva posato su un greppo della stradina in discesa per giocare ad acchiappino con delle amiche incontrate per caso, era ruzzolata, forse per un colpo di vento, rompendosi in cento frantumi. Che cosa avrebbe mai detto alla mamma che l’aveva mandata a prender acqua?
Fina, dopo aver pregato il Signore, comandò alla piccina di riunire tutti i pezzetti, ricomporre la brocca e riempirla d’acqua. Smeralda, che aveva tanta fiducia in lei, obbedì fra la curiosità delle compagne che si trasformò in meraviglia quando si accorsero che la brocca si era ricomposta perfettamente. V’è da osservare che l’episodio della brocca ricomposta doveva essere un toposdell’epoca se a proposito della contemporanea santa Rosa da Viterbo si raccontava un episodio simile.
Questa e altre leggende sui miracoli di santa Fina prima e dopo la morte sono state raccolte diligentemente da Enrico Castaldi in Santa Fina nelle testimonianze dei coetanei e nei ricordi dell’arte(San Gimignano 1927): molti miracoli sono stati rappresentati, come ad esempio la resurrezione di un morto su uno dei bassorilievi dell’altare marmoreo, nella cappella di Santa Fina della collegiata, scolpiti da Benedetto da Maiano nel 1475. Su un tabernacolo di Lorenzo di Niccolò Gerini (1324-1411), oggi custodito nel Museo Civico, figurano invece un incendio domato, la liberazione di un indemoniato, la salvezza da un naufragio e infine una caduta da un tetto senza conseguenze.
Ma il miracolo maggiore fu la costruzione dello Spedale di Santa Fina per i malati poveri che fu possibile grazie alle cospicue offerte della popolazione sul suo sepolcro. Due anni dopo la sua morte doveva già funzionare perché i suoi Statuti risalgono al 1255. Nell’ospedale, che esiste ancora oggi pur col nome mutato, fu trasferita la tavola di quercia su cui era vissuta per cinque anni la fanciulla. La si conserva nella cappella dove vi sono anche i due busti di san Gregorio e di santa Fina scolpiti in marmo policromo da Pietro Torrigiano (1427-1528).
Tutta San Gimignano è costellata di immagini della santa che tradizionalmente ha come attributi un mazzo o un tralcio di fiori. Così la vediamo nell’affresco di Benozzo Gozzoli nella chiesa di Sant’Agostino: col volto quasi infantile e dolcissimo, il mantello che ricade elegantemente sulle spalle e i fiori nella destra. Nella pala d’altare di Lorenzo di Niccolò (1402), al Museo Civico, appare invece alta e sottile con un volto severo da Madonna senese, un mazzo di fiori nella destra e sulla sinistra, contro il petto, il modellino di San Gimignano.
Ma è nella collegiata, l’antica pieve ampliata nel 1460 da Angelo da Maiano, il cuore della sua iconografia come del culto grazie ai molti affreschi, tavole e sculture e a quel capolavoro del rinascimento che è la cappella di Santa Fina, opera di Giuliano da Maiano ( 1466-1468), dove lavorarono, come s’è già ricordato, Benedetto da Maiano, il Ghirlandaio, Pier Francesco Fiorentino e Sebastiano Mainardi. Nell’altare marmoreo è conservato anche il busto reliquiario con il teschio di santa Fina, scolpito da un artista senese del primo Trecento, che viene custodito nel tabernacolo ed esposto soltanto il 12 marzo e la prima domenica d’agosto, quando se ne ricorda un altro miracolo: nel 1479, grazie alla sua intercessione, cessò miracolosamente un’epidemia di peste che stava decimando la popolazione.
Santa Fina di San Gimignano nacque il 1238
Santa Fina di San Gimignano nacque a San Gimignano
Santa Fina di San Gimignano morì il 12/03/1253
- San Gimignano (Toscana)
Santa Fina di San Gimignano si festeggia il 12 marzo